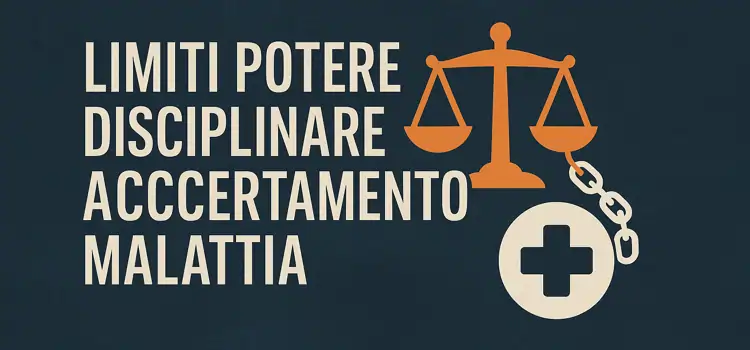
I limiti del potere disciplinare: l’inammissibilità dell’accertamento “preventivo” dei fatti di malattia
(Cass., ord. 16 ottobre 2025, n. 27671)
L’ordinanza in commento si inserisce nel filone delle pronunce volte a delimitare il perimetro applicativo dell’art. 100 c.p.c., riaffermando la funzione di questa disposizione come condizione di serietà e di proporzionalità dell’accesso alla tutela giurisdizionale.
La Corte di cassazione ne fa applicazione in un caso peculiare, in cui il datore di lavoro aveva tentato di utilizzare il processo non per la tutela di un diritto leso, ma come strumento di verifica preliminare dell’esistenza di presupposti fattuali di un eventuale illecito disciplinare.
Il caso concreto
Una società, insospettita da ripetute e concomitanti assenze per malattia di due coniugi dipendenti, aveva chiesto al giudice di accertare la reale gravità delle patologie e la loro idoneità a giustificare l’assenza dal lavoro.
L’iniziativa si fondava sull’assunto che la coincidenza dei periodi di malattia (167 giorni complessivi in quattro anni e mezzo) e le risultanze di accertamenti investigativi - dai quali emergeva una vita quotidiana normale e attiva - generassero una situazione di oggettiva incertezza, tale da impedire al datore di lavoro di valutare se e come esercitare il potere disciplinare.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Bologna avevano dichiarato inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire, ritenendo che l’accertamento richiesto riguardasse meri fatti, e non un diritto soggettivo attuale.
La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 100 c.p.c. e sostenendo che l’interesse ad agire potesse fondarsi su una semplice incertezza oggettiva circa un fatto giuridicamente rilevante, indipendentemente dall’esistenza di una lesione effettiva.
Il principio affermato
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e ribadisce il principio, già espresso da un orientamento consolidato (Cass. S.U. 27187/2006; Cass. 11730/2024; Cass. 18819/2018; Cass. 12532/2024), secondo cui l’interesse ad agire deve essere concreto, attuale e riferito a una situazione di diritto: non è sufficiente un’incertezza di fatto, né la mera possibilità che un comportamento futuro possa incidere su posizioni giuridiche ancora solo eventuali.
L’interesse ad agire, precisa la Corte, non può essere invocato come strumento di “assicurazione preventiva” rispetto all’esercizio di poteri discrezionali, poiché la funzione del processo non è quella di validare ex ante l’operato delle parti, ma di ristabilire un equilibrio giuridico a fronte di una lesione già verificatasi.
L’azione di mero accertamento è ammissibile solo se diretta a rimuovere un’incertezza su un rapporto o su un diritto già in essere, non quando l’incertezza riguardi un fatto destinato, al più, a costituire in futuro elemento di un rapporto giuridico.
L’inammissibilità dell’accertamento “esplorativo”
Sulla scia di Cass. 4587/2014, la pronuncia chiarisce che non è consentito adire il giudice per verificare, in via preventiva e astratta, se un determinato comportamento del lavoratore – reale o sospettato – possa integrare una violazione disciplinare.
Un simile accertamento, osserva il Collegio, contrasterebbe con i principi di immediatezza e tempestività della contestazione, che presidiano la buona fede e la correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, lungi dall’essere titolare di un “diritto alla certezza”, deve assumersi la responsabilità della valutazione dei fatti e dell’eventuale esercizio del potere disciplinare, il cui controllo di legittimità è previsto solo ex post.
Il processo, in questa prospettiva, non è una zona di sicurezza nella quale il datore possa rifugiarsi per ottenere conferme sulle proprie scelte gestionali, ma un rimedio eccezionale e indispensabile per la tutela di diritti soggettivi effettivamente compromessi.
La pretesa di adoperarlo come sede di consulenza preventiva si tradurrebbe in un abuso dello strumento processuale, in contrasto con il principio di economia e con la stessa nozione di “indispensabilità della giurisdizione” affermata dalle Sezioni Unite del 2006.


Il potere disciplinare e gli strumenti di verifica
La Corte osserva che l’ordinamento già mette a disposizione del datore di lavoro una pluralità di strumenti per la verifica dell’effettività delle assenze per malattia: dalla visita fiscale agli accertamenti del medico competente, fino alle indagini compatibili con la normativa sulla privacy.
È inoltre possibile, all’esito di tali riscontri, attivare la procedura disciplinare di cui all’art. 7 L. 300/1970, che consente di verificare la realtà dei fatti nel contraddittorio delle parti, senza che sia necessario un intervento giudiziale preventivo.
Da ciò discende che l’interesse ad agire non può essere individuato nel mero desiderio di “non sbagliare” nella valutazione dei fatti, perché la discrezionalità datoriale implica anche un margine fisiologico di rischio e di autoresponsabilità.
Il processo non può essere trasformato in un organo di garanzia preventiva delle scelte imprenditoriali.
Profili sistemici e riflessi pratici
Il ragionamento della Cassazione si inserisce in una visione del processo civile come strumento di tutela selettiva: solo chi subisce una lesione effettiva di un diritto può accedere alla giurisdizione.
In tal senso, l’art. 100 c.p.c. funge da clausola di chiusura contro l’utilizzo deflattivo o esplorativo del giudizio, assicurando che la macchina della giustizia resti proporzionata alla necessità effettiva di tutela.
Sul piano sostanziale, la decisione rafforza l’idea che il potere disciplinare, pur ampio e unilaterale, deve essere esercitato entro i confini della buona fede e della correttezza, ma senza ricorrere al giudice per ottenere una “copertura preventiva”.
La certezza dell’azione datoriale non nasce dal processo, bensì dall’osservanza delle procedure e dei principi di lealtà e tempestività.
Conclusioni
L’ordinanza n. 27671/2025 costituisce un ulteriore tassello nella costruzione di una giurisprudenza che riafferma la natura responsabile e limitata della giurisdizione: il processo non può essere un laboratorio di ipotesi o un terreno di sperimentazione per decisioni datoriali ancora incerte.
Solo la lesione concreta di un diritto legittima la tutela giudiziale, mentre la volontà di prevenire errori o di ottenere rassicurazioni non integra l’interesse ad agire.
Il principio, letto in chiave sistematica, tutela non solo l’economia processuale, ma anche la libertà d’impresa e l’autonomia della gestione datoriale: libertà che implica il rischio dell’errore, ma non ammette la delega preventiva al giudice di valutazioni che appartengono al merito del rapporto di lavoro.
Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 264 del 11 Novembre 2025 - da Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria
Immagine di apertura: elaborazione su Foto generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay





