
La prima sentenza della Cassazione sulle collaborazioni organizzate dal committente
(Commento a Cass. 24 gennaio 2020 sui rider di Foodora)
L’attesa della sentenza della Suprema Corte è stata spasmodica. Forse per questo ha un po' deluso, tradendo le attese di chi si aspettava una motivazione meno perplessa, più lineare; indicazioni più precise per interpretati disorientati dalla norma più ipocrita ed enigmatica mai scritta nel nostro martoriato diritto del lavoro.
1 - Riassunto delle puntate precedenti
- La prima puntata
Il Tribunale di Torino, nel rigettare totalmente il ricorso proposto da alcuni rider di Foodora, aveva in estrema sintesi ritenuto che non avessero provato né il vincolo della subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. né il vincolo della eterorganizzazione di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81 del 2015: un vincolo, il secondo, ritenuto addirittura più forte del primo.
Era stata così accolta la tesi “dottrinale” sostenuta dalla difesa di Foodora secondo cui la norma di cui all’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 81 del 2015 “non ha un contenuto capace di produrre nuovi effetti giuridici sul piano della disciplina applicabile alle diverse tipologie di rapporti di lavoro”, perché “così come è stata formulata viene quindi ad avere addirittura un ambito di applicazione più ristretto di quello dell’art. 2094 c.c.”.
Una norma apparente, dunque.
Il ricorso era stato così integralmente rigettato in primo grado.
- La seconda puntata
La tesi della norma apparente, e del legislatore ipocrita, era stata sconfessata invece dalla Corte d’Appello di Torino.
Una norma giuridica un senso deve averlo per forza e comunque bisogna cercarlo.
Ed il senso scovato è che le collaborazioni etero-organizzate sarebbero un tertium genus tra lavoro autonomo e subordinato, cui si applicherebbe per estensione la disciplina del lavoro subordinato.
Ma non tutta.
Solo quella parte compatibile con la natura non subordinata del rapporto.
Sarebbero “compatibili” le norme sulla sicurezza, sulla retribuzione, sui limiti di orario, sulle ferie, nonché le norme previdenziali.
Non sarebbero compatibili, invece, le norme sui limiti al potere di licenziamento ed al contratto a termine.
Di qui l’accoglimento parziale del ricorso: condanna al pagamento delle differenze retributive per i dipendenti di V livello di cui al CCNL Logistica-trasporto merci; rigetto delle domande relative all’illegittimità del recesso per ontologica incompatibilità con la natura non subordinata del rapporto.
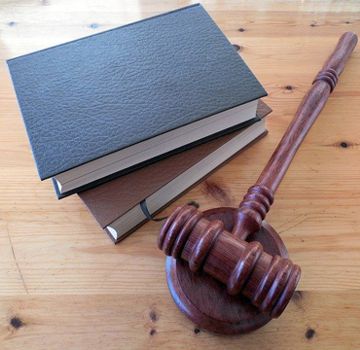

2 - L’ultima puntata in Cassazione
L’attesa della sentenza della Suprema Corte è stata spasmodica.
Forse per questo ha un po' deluso, tradendo le attese di chi si aspettava una motivazione meno perplessa, più lineare; indicazioni più precise per interpretati disorientati dalla norma più ipocrita ed enigmatica mai scritta nel nostro martoriato diritto del lavoro.
Contro la sentenza ha proposto però ricorso soltanto Foodora.
I rider hanno resistito con controricorso, ma non hanno proposto ricorso incidentale sulla statuizione di rigetto della domanda di accertamento della subordinazione (ritenuta probabilmente incensurabile in sede di legittimità); né sulla statuizione di applicazione parziale della disciplina del lavoro subordinato con riferimento alla accertata ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 81 del 2015 (questione che sarebbe stata certamente deducibile in sede di legittimità).
Hanno così sprecato l’occasione di ottenere l’integrale applicazione della disciplina del lavoro subordinato ed in particolare l’accertamento dell’illegittimità del recesso.
E probabilmente si saranno mangiati le mani. Secondo la Suprema Corte se ricorre la (non) fattispecie delle collaborazioni organizzate dal committente l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato è integrale, ivi compresa la disciplina limitativa dei licenziamenti.
Ed è questa la prima grande differenza rispetto alla sentenza della Corte d’Appello di Torino, con (irrilevante) correzione della motivazione, confermata nel dispositivo, non avendo come detto i rider proposto ricorso incidentale.
In altra parte di motivazione, però, si osserva, un po' contraddittoriamente rispetto alla ritenuta applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato, che “non possono escludersi situazioni in cui l’applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non sono comprese nell’ambito dell’art. 2094 cod. civ.”.
La questione, però, non viene approfondita perché “si tratta di questione non rilevante nel caso sottoposto all’esame di questa Corte”.
La seconda grande differenza rispetto alla sentenza della Corte d’Appello di Torino (corretta anche sul punto nella motivazione) è nell’avere la Suprema Corte “ritenuto l’art. 2, comma 1, d.lgs. 81 del 2015 norma di disciplina e non norma di fattispecie, dovendosi escludere che essa abbia dato vita ad un tertium genus, intermedio tra la subordinazione ed il lavoro autonomo”.
Non integrando una “fattispecie” o un “tertium genus” le collaborazioni organizzate dal committente finiscono per essere investite da una crisi di identità.
Il legislatore nell’abrogare la disciplina del lavoro a progetto “che prevedeva vincoli e sanzioni” e nel tornare alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, e, dunque, una volta “ripristinata una tipologia contrattuale più ampia che come tale comporta il rischio di abusi”, avrebbe semplicemente voluto rendere “più facile l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato” quale misura antielusiva compensativa e con un “approccio rimediale”.
E del resto, osserva sempre la Corte, è questa la direzione presa dal nuovo art. 2, comma 1, D.lgs. n. 101 del 2019 sostituito dall’art. 1 del decreto-legge n. 101 del 2019 convertito in legge 128 del 2019.
Un approccio rimediale che consiste in ciò: “quando l’etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”.
Ma allora si tratta di lavoro subordinato?
Magari secondo una nozione allargata ed attenuata?
No o non necessariamente. Potrebbe benissimo trattarsi di lavoro autonomo caratterizzato da intensa parasubordinazione, e comunque non di “una vera e propria subordinazione”, come ribadisce la Suprema Corte nell’osservare che non si può escludere che il giudice, non accontentandosi di accertare l’eterorganizzazione, “accerti in concreto la sussistenza di una vera e propria subordinazione rispetto alla quale non si porrebbe neanche un problema di disciplina incompatibile”.
Dunque, non è importante distinguere.
Domandarsi se si tratta di lavoro autonomo o subordinato.
Né ipotizzare un nuovo tipo intermedio di lavoro. Un quartum genus se si considerano anche le collaborazioni auto-organizzate di cui al nuovo art. 409 n. 3 c.p.c.
Il legislatore agendo “in una terra di mezzo dai confini labili” in una “zona grigia tra autonomia e subordinazione” non avrebbe dunque creato una nuova fattispecie, ma si sarebbe “limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l’applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta e senza che questi possa trarre, nell’apprezzamento di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi”.
Nel dubbio, se ricorrono e sono provati quegli indici, il giudice dovrà applicare la disciplina del lavoro subordinato, senza dover qualificare, come autonome o subordinate, le collaborazioni che ne sono caratterizzate.
Per dirle con le parole della Suprema Corte “non ha decisivo senso interrogarsi se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell’autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina”.
Un siffatto “approccio rimediale”, l’essere, secondo la Suprema Corte, l’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 81 del 2015 norma di disciplina e non di fattispecie, dovrebbe consentire l’esame della domanda di applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche se basata esclusivamente sull’art. 2094 c.c. e non sull’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 81 del 2015 (che in una siffatta prospettiva non introdurrebbe una distinta causa petendi), in base al principio secondo cui il giudice ha il potere-dovere di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame.
La sentenza della Suprema Corte non affronta le ricadute di una siffatta impostazione sulle ipotesi di collaborazioni etero-organizzate alle quali non si estende la disciplina del lavoro subordinato previste dall’art. 2, comma 2, D.lgs. n. 81 del 2015 (collaboratori iscritti ad un albo, o assoggettati a discipline specifiche previste da accordi collettivi nazionali, come ad esempio per gli addetti ai call center e via dicendo).
Per i collaboratori in questione la giurisprudenza aveva coniato il concetto giuridico di subordinazione attenuata, assai poco distinguibile dal concetto giuridico di collaborazione etero-organizzata di cui all’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 81 del 2019, cosicché davvero non si comprende il senso della prevista non applicabilità della suddetta disposizione finalizzata all’estensione della disciplina del lavoro subordinato.
Qui davvero il giudice dovrebbe fare finta di niente, rinunciano a dare un senso ad una norma che se lo avesse, comporterebbe la non applicabilità delle tutele del lavoro subordinato a lavoratori che prima ne beneficiavano in base al concetto della subordinazione attenuata, e che, dunque, avrebbe probabilmente infranto il principio della indisponibilità del tipo lavoro subordinato.
Non a caso, i giuslavoristi più “illuminati”, pronti ad insegnarci come si protegge il lavoro nella gig-economy, auspicano fortemente che la contrattazione collettiva intervenga ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), e dell’art. 47-quater del D.lgs. n. 81 del 2015 per evitare l’estensione della disciplina del lavoro subordinato ai collaboratori assiepati nella zona grigia o di confine ed in particolare ai collaboratori delle piattaforme digitali, introducendo regole in materia di tempo di lavoro e di struttura della retribuzione compatibili con l’organizzazione del lavoro.
Tratto da "Sentenze e Commenti" - Febbraio 2020 - Uno dei servizi dell'Abbonamento ISPER





